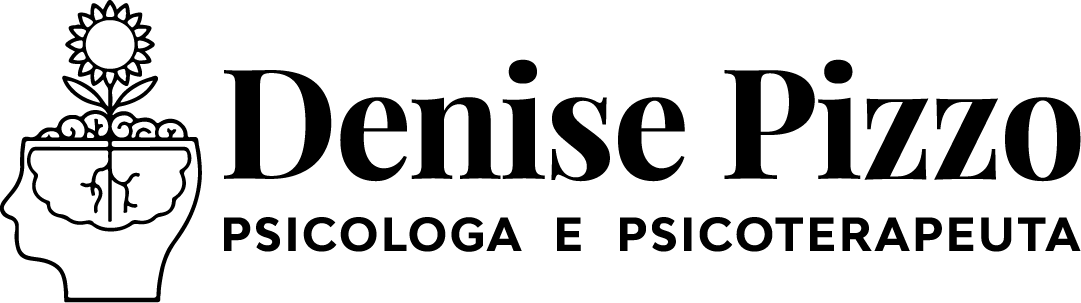Un anno di Covid.
Siamo giunti alle porte della primavera in (semi)lockdown, bardati di mascherina e con i reparti di terapia intensiva di nuovo al limite, senza la possibilità di festeggiare la Pasqua – un’altra – con chi amiamo.
E siamo stanchi, lo siamo davvero. Ci manca la nostra vita “normale”: ci mancano i viaggi, i concerti, gli aperitivi e le cene in ristorante. A me manca mangiare dallo stesso piatto di cinese dei miei amici, mettere il rossetto, mancano le mie amiche fuori regione, le lezioni in presenza, la spensieratezza di toccare ovunque senza mai lavarmi le mani (sì, questo forse non era un comportamento funzionale neanche prima del Covid!), mancano i visi dei miei pazienti e i corsi di gruppo.
Gennaio 2020 e le prime notizie da Wuhan, gli allarmismi degli esperti e le smentite di chi diceva: “ma sì, è come un’influenza!”; e poi a febbraio quel nemico invisibile che arriva ad annidarsi sotto casa: il primo caso a Vo’ Euganeo, la chiusura dell’ospedale di Schiavonia e poi le persone che conosci che hanno iniziato ad ammalarsi – e a morire. E quel maledetto virus non sembrava più una cosa che non ti riguardava.
E così, da un giorno all’altro il mondo intero si ferma: chiuse le scuole, chiuse le palestre, i bar e i ristoranti, i musei e i teatri, ferma la produzione, i concerti, le partite di calcio e gli aperitivi. Il Covid-19, come spada di Damocle, pende sul capo di tutti noi ammonendoci di fermarci. E l’abbiamo fatto. Eccome se l’abbiamo fatto!

Abbiamo sospeso la nostra vita per un po’ e messo in pausa noi, le nostre vite, i nostri sogni e progetti. Abbiamo avuto paura, ci siamo arrabbiati, ci siamo sentiti impotenti. Abbiamo assistito a scene di scempi di lieviti nei supermercati e di Amuchina gel in farmacia, abbiamo visto proiettare nei nostri schermi tv le facce sfinite con i solchi delle mascherine di medici e infermieri, e chi dimentica poi quelle terribili immagini dei mezzi militari che trasportavano le salme a Bergamo? I giornali descrivevano uno scenario di guerra apocalittica in un’Italia sprofondata in un silenzio surreale.
Ma poi, i malati hanno iniziato a guarire, i contagi sono scesi, si è iniziato a parlare di vaccino. E nei balconi di casa comparivano arcobaleni disegnati dai bambini o qualche simpatico svitato che urlava: “Ce la faremo!”. E le nostre giornate spogliate della frenesia della vita performante, della rincorsa degli appuntamenti in agenda e del consumismo compulsivo si sono riempite, gradualmente, di condivisione, di dolci e pizze fatte in casa, di giochi da tavolo. C’è chi ha riscoperto il tempo con i propri cari, chi ha telefonato amici che non sentiva da tempo, chi si è scoperto pollice verde o influencer con dirette Instagram, chi ha ricaricato le pile, chi ha studiato e fatto corsi di aggiornamento, chi ha svecchiato la propria professione con il digitale, chi ha rivalutato la propria scala di valori e priorità di vita. La resilienza ha riconsiderato questo stop forzato come un’officina nella quale fabbricare nuove idee.

E le strade sgombre con le saracinesche dei negozi abbassati hanno via via iniziato a ripopolarsi di persone, prima con la mascherina e poi senza. In estate abbiamo provato l’ebbrezza di tirare un sospiro di sollievo, di sfoggiare rossetti dai colori cangianti; qualcuno ha osato viaggiare e abbiamo iniziato di nuovo a progettare e a sperare.
A ottobre arriva la “seconda ondata” come l’hanno definita gli esperti: l’incubo si riattualizza. Chiudiamo e/o apriamo, mettiamo in stand-by le idee, mascherina su di nuovo. E quindi ancora: paura, impotenza e, soprattutto, rabbia. Ma come?! Noi ci siamo comportati bene e abbiamo seguito le regole, non è giusto limitare la nostra libertà di nuovo! E le teorie complottiste dilagano nutrite di bias che hanno bisogno di trovare un colpevole in tutta ‘sta storia. La speranza del vaccino e nesiamofuorientrosettembre sfumano a fronte di una confusione epistemologica tra ‘correlazione’ e ‘causalità’. E qui si aggiunge la rassegnazione.
La rassegnazione è staticità, immobilità, rigidità, chiusura: è credere che le cose saranno per sempre uguali.
Ma la realtà è mutevole, fluida, impermanente: rassegnarsi significa rinunciare a vivere.
Un antidoto? L’accettazione. Accettazione significa aprirsi e fare spazio a ciò che accade: significa vivere nel presente e coltivare la flessibilità.
Cosa non posso cambiare e quindi devo accettare? Cosa invece posso cambiare? C’è sempre una scelta.
E per cambiare devo fare i conti con le cose così come sono: è l’accettazione che permette il cambiamento in un sottile equilibrio dialettico.
Tutto questo non può durare per sempre.

Photo Credit: Lorenzo Quinn
Nel frattempo, validiamo le nostre emozioni: è normale sentirsi arrabbiati, soli, sfiduciati, impotenti, tristi. È normale! Combattiamo questo virus uscendo dalla visione egoista e egocentrica che, a quanto pare, non funziona. Ora più che mai sono richieste reciprocità, interconnessione, communitas nel senso etimologico di condivisione: solo abbandonando la visione idiosincratica su cui si ci siamo arroccati, possiamo venir fuori da questa crisi che coinvolge tutti. Solo se tutti riscopriamo quel senso civico di responsabilità sociale, il virus può essere sconfitto. Siamo esseri interconnessi: ce lo diceva 2500 anni fa il Buddha, ce lo dice ora la fisica quantistica.
Ne usciremo sì, e – spero – con una consapevolezza diversa.